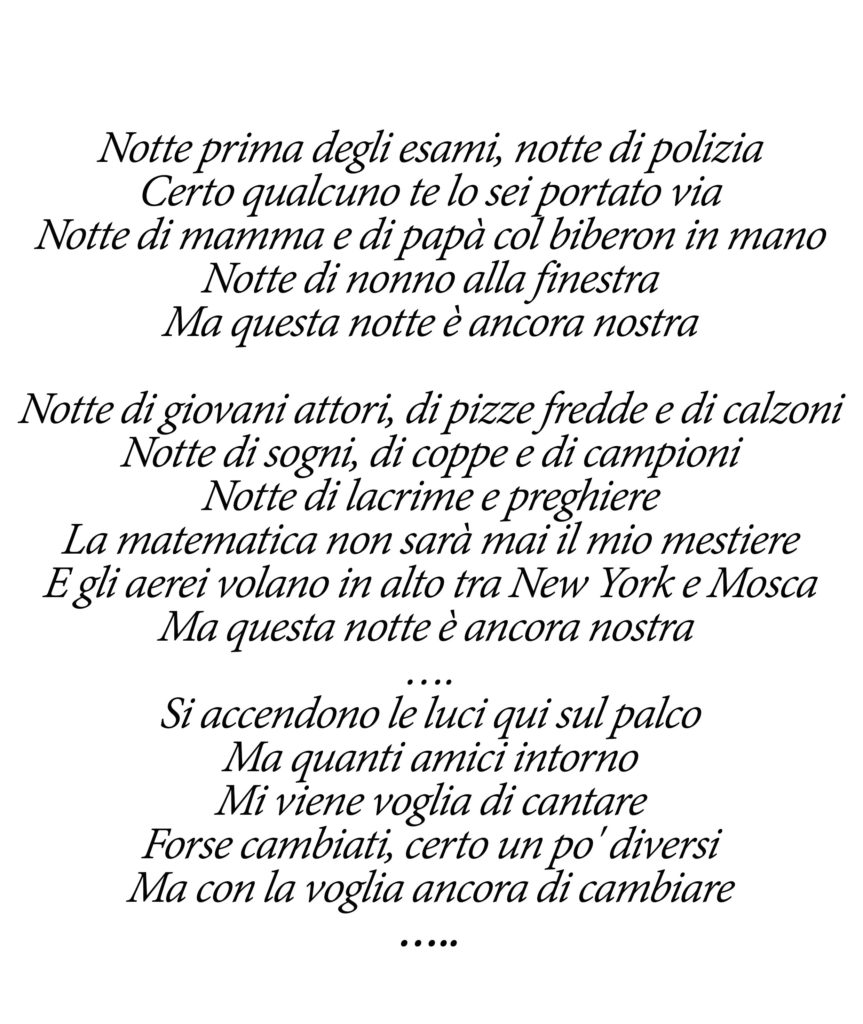di Lea Del Negro*
Ci penso ogni tanto alla mia adolescenza, ma non la rimpiango. Se esistesse la macchina del tempo non tornei negli anni Ottanta a Pordenone, per vedermi con il fiocco di pizzo bianco in testa ad imitare Madonna e le scarpe finte Timberland. Non sono mai stata un’adolescente tormentata, ma ripensando a me stessa mi sento cogliere da una certa tenerezza mista ad imbarazzo. A quella ragazza sono di certo mancati dei modelli importanti, una figura di riferimento carismatica: mi piacevano tutte le cose che ora mi fanno storcere il naso, come la musica di Eros Ramazzotti tanto per dare un’idea.
Lo ricordo come un periodo di transizione, sereno, ma di preparazione ad altro. Sarà che ho frequentato la Ragioneria, che mi faceva abbastanza schifo, solo per corrispondere alle aspettative dei miei genitori. Ecco, io l’adolescenza, il periodo delle scuole superiori, l’ho trascorso in attesa di fare altro, di avere un po’ di indipendenza, soprattutto di pensiero. Poi finalmente finite le superiori sono potuta andare all’Università (Lettere) ed è cambiato tutto. Dopo anni in trincea senza grandi aspettative ero al posto giusto nel momento giusto. Gli anni opachi delle superiori si sono allontanati: è stato come mettere gli occhiali dopo un periodo di miopia e vedere tutto brillante. Agli incontri di presentazione i docenti come prima cosa ci avevano avvertito che stavamo scegliendo una facoltà anacronistica, con pochi sbocchi lavorativi, fatta eccezione per l’insegnamento. Questo mi aveva motivata ancor di più: che sfida riuscire a vivere di letteratura.

Ma come ero giunta a quella scelta? I libri erano importanti per me? Sono cresciuta con loro, desiderandoli, ma senza mai averne un accesso diretto. Da piccola in casa ne avevo alcuni che leggevo ossessivamente (Heidi, Senza famiglia, Piccole donne, le fiabe di Andersen ecc.), ma erano altri tempi e le biblioteche non erano accessibili ai piccoli come lo sono ora. Non che fosse vietato andarci, ma …. la mia biblioteca cittadina era immersa nel grigiore delle proprie scaffalature. Il mio primo ingresso si era risolto in una grande delusione, soprattutto perché nessuno al bancone del prestito aveva colto il mio spaesamento, aiutandomi a cercare qualcosa che potesse piacermi. Sono tornata in quel grigiore solo molti anni dopo, da universitaria, già in grado di muovermi autonomamente per le sale, ma della mia prima esperienza mi è rimasto un rimpianto, un qualcosa di irrisolto che ora invece ho risolto benissimo. Se parliamo invece di librerie non era abitudine dei miei genitori portarmici, tanto che molti dei libri che possedevo mi erano stati regalati.

Mi piaceva follemente leggere, ma lo facevo in modo bulimico e senza selezionare, andava bene tutto quello che trovavo. Per me era lo stesso passare dagli Harmony di mia nonna, agli Agatha Christie delle mie cugine, leggendo, se non avevo altro, il giornale di mia madre e non stavo a sottilizzare se fosse Confidenze o Grand Hotel. Bramavo le storie, volevo leggere. A pensarci ha un senso, alla luce della professione che ho scelto.
All’Università ho recuperato tutti gli arretrati e ho letto, letto e letto senza averne mai abbastanza, persino delle cose pesanti e noiose che ora non avrei più la forza di affrontare. Terminati gli studi, prestando volontariato presso una piccola biblioteca di quartiere ho incontrato quella che ora è una delle mie migliori amiche e che già all’epoca aveva le idee molto chiare sulla sua futura professione. Lei voleva fare la bibliotecaria. Che idea stupenda la sua! Non poteva adattarsi anche a me? Non me ne sono mai pentita.

Questo lavoro mi ha dato tantissimo e mi mantiene in contatto con le persone e con le storie. Posso dire di essermi anche riappropriata della mia adolescenza e la sento più vicina ora che allora; la vedo ogni giorno nei volti dei miei giovani utenti, quelli che chiedono un consiglio e quelli che non vogliono che io rompa loro le scatole. La mia biblioteca deve essere associata al colore e non al grigiore e soprattutto deve essere associata al calore, perché nessun giovane utente possa entrare e sentirsi respinto. Tra gli scaffali ci sono oltre 18.000 storie che aspettano di venir lette e sono tutte alla ricerca di un lettore. Io sono un po’ la prescelta a far nascere questi incontri. Il panorama editoriale per ragazzi al momento è ricco e composito e io mi ci perdo dentro: sono i libri che avrei voluto che qualcuno mi consigliasse all’epoca! Non importa, nonostante il ritardo, quelle storie sono anche per me, c’è sempre tempo per migliorarsi, apprendere e conoscere. C’è sempre tempo per leggere.

Negli ultimi tempi, con un’amica conosciuta in biblioteca, ho anche aperto un blog; scriviamo dei libri che ci sono piaciuti, quindi anche nel tempo libero cerco di fare quello che faccio al lavoro, promuovere la lettura. Ho questa assurda e incrollabile convinzione che il mondo potrebbe essere un posto migliore se si leggesse di più, perché entrare in diverse trame e storie stimola l’empatia. Leggendo riesci a comprendere anche le ragioni degli altri e quando questo accade l’altro non è più ALTRO. Immagino di essere ancora un’idealista. Se è un difetto spero di non perderlo mai.
Torno indietro con il pensiero alla me adolescente e mi sorrido da una distanza siderale. Mi piace quello che sono diventata e ho ancora margine per un miglioramento, un’ottima motivazione per affrontare ogni giornata.
Dimenticavo…ora ascolto gli AC/DC. 😊

* Impiegata dal 2000 in qualità di bibliotecaria presso un Ente locale. Organizzatrice per conto del proprio Comune della rassegna “Prata d’autore” (che ha ospitato, tra gli altri, autori come Ilaria Tuti, Enrico Galiano, Andrea Maggi, Matteo Bussola, Francesco Vidotto e Sara Rattaro. Dal 2005 insieme a Stefania Baccichetto cura un blog che si occupa di libri per adulti e ragazzi (Duettriciquasiperfette).