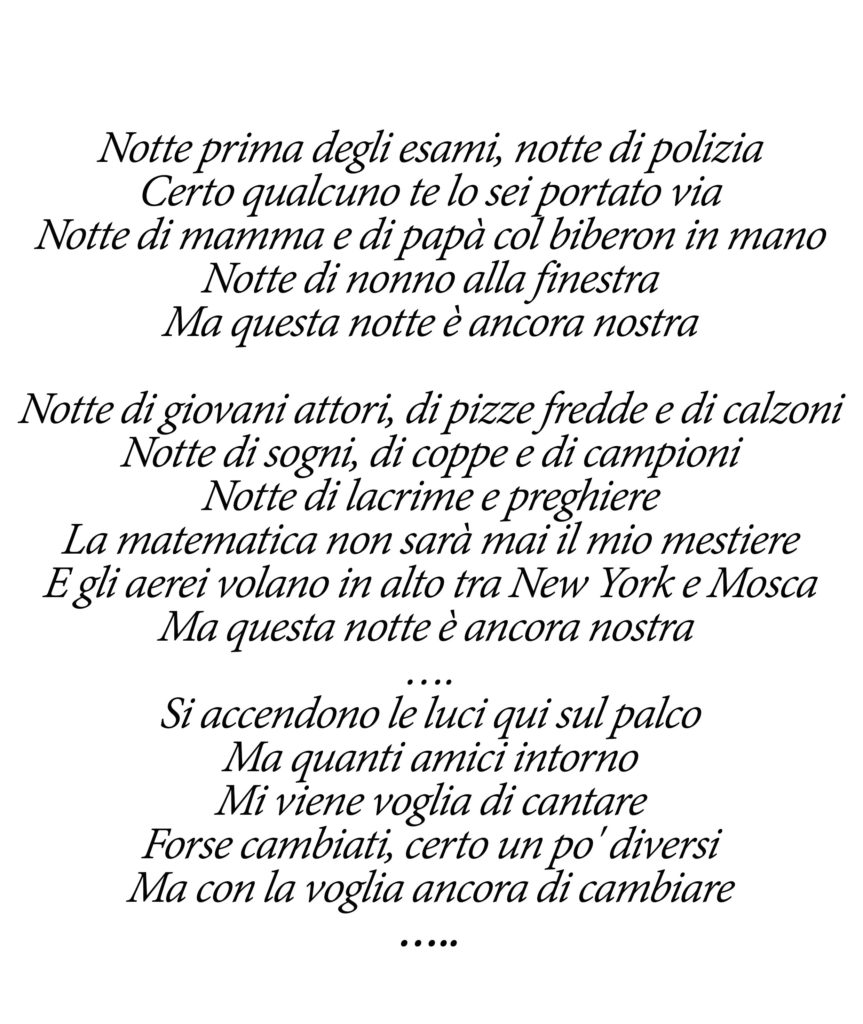di Sara Feltrin

Poche settimane fa su Teen&20 scrivevo un articolo, La guerra dentro, nel quale descrivevo il forte malessere e la profonda sofferenza che caratterizza la gran parte degli adolescenti di oggi, chiusi e bloccati dentro le mura domestiche, come pettirossi in gabba, rossi dalla rabbia.
La guerra, ora, è scoppiata davvero.
Le manifestazioni con cui i giovani hanno provato a farsi sentire e urlare a gran voce nelle piazze o fuori della scuola, vestiti a strati con berretto, guanti e una coperta stesa a terra come clochard lungo la strada, sono state parecchie. Telegiornali e notiziari ne hanno parlato molto, li hanno intervistati, ma nulla è cambiato. I continui DPCM tentennano tra salvare il mondo da una pandemia mondiale e l’Italia da un collasso economico, lasciando aperti fino a sera i centri commerciali per i regali di Natale, ma le scuole perennemente chiuse.

Risale a pochi giorni fa (5 dicembre 2020) la vicenda presso il Pincio di Roma in cui centinaia di giovani, gran parte minorenni, si sono raccolti, un sabato pomeriggio, per assistere ad una rissa tra due ragazze. Una di loro, però, non si è presentata ma ciò nonostante la rissa è esplosa lo stesso, tra gruppi di ragazzini guidati da rabbia e sete di vendetta. La diretta e inevitabile conseguenza è stato quindi un grande affollamento di centinaia di giovani arrabbiati che, senza l’utilizzo di mascherine, si è ribellato nel centro di Roma. Ma i pugni, incitamenti, aggressioni, e violenze scagliate uno contro l’altro, nonostante l’intervento delle Forze dell’Ordine in tenuta anti sommossa, non sono bastati a frenare la rivolta.
E su Tik Tok, Telegram e WhatsApp, circola già il messaggio “Confermata al 100% la rissa il prossimo sabato” ma sta volta i pugni e calci non basteranno e le armi della “rivincita” saranno lame e coltelli.
Ci impressioniamo di tanta violenza, maleducazione, vandalismo e intemperanza. Questo, alla fine, colpisce. L’attenzione è diretta alle conseguenze più che alle cause e si cerca un modo per frenarli e disarmarli con tute antisommossa quando invece dovremmo fermarci ad ascoltarli, con le parole. Perchè mettersi ancora contro di loro non fa altro che aumentare la distanza, e più saranno lontani e più loro urleranno.
I numeri parlano chiaro: dallo scorso anno il numero degli atti vandalici provocato da ragazzi nella fascia adolescenziale è aumentato dal 16% al 22%; le risse ora sono al 24%, l’utilizzo di armi o oggetti pericolosi all’8% e l’aggressività su persone al 35% (Osservatorio Nazionale Adolescenza).
I nostri non sono più ragazzi e adolescenti che si ribellano per trovare dei limiti o dei confini per la definizione di sè; sono ragazzi demotivati, arrabbiati; sono adolescenti stufi di ribellarsi e che quindi, lottano. Lottano (o meglio, lottavano) a scuola dove attenzione e concentrazione sembrano capacità irraggiungibili e una buona comunicazione con insegnanti e compagni una grande utopia. Lottano nelle strade contro una società che li giudica e li considera un peso anziché una ricchezza. Lottano infine nelle piazze, unico luogo in cui ritrovare la voce e le urla dei coetanei arrabbiati e sconfortati come loro per scagliarsi insieme contro un mondo che non dà opportunità e sa di amaro. Ma lottano soprattutto in casa e in camera in particolare, contro se stessi. Mancano obiettivi, tante volte mancano perfino i sogni, mancano figure solide, mancano punti di riferimento verso le quali dirigere la rotta, manca la rotta e manca la motivazione che lascia spazio alla noia. E la noia di un vuoto, soprattutto in un’età in cui istinti e ormoni prendono il sopravvento, porta a frustrazione e percezione di scarsa autoefficacia (non faccio quindi non imparo quindi evito di fare per non fallire). Mettiamoci un futuro senza certezze del domani, una pandemia in corso che limita gli spostamenti bloccando i contatti fondamentali e la ricetta è pronta.
Così, abbandonati alla noia e all’angoscia, l’unica strada rimane quella dell’esplorare l’oltre, una pseudo realtà fatta di adrenalina e autoefficacia che restituisce sensazioni di libertà, coraggio, competenza e vita. Ed ecco che spesso si ricorre all’alcol, alla droga, alla violenza, ai killer selfie, ai knockout, alle challenges virali spesso mortali, sfide ricche di sensazioni fortissime, devianze nate non più per raggiungere dei limiti ma per scavalcarli.
E’ una guerra spietata quella che sentono dentro e ce lo stanno dimostrando in tutti i modi, arrivando a volte persino al suicidio.
Ora tocca a noi ascoltarli, senza giudicarli e senza pretendere da loro chi vorremmo che fossero, ma accettiamoli, comprendiamoli e aiutiamoli con tutti gli sforzi che stanno facendo per crescere in un mondo così astioso come l’attuale. Hanno bisogno di noi, figure di riferimento, autorità competenti e persone da stimare che possono insegnare loro come sconfiggere lo sconforto e la frustrazione, per recuperare i sogni perduti e per poter credere che dopo ci sarà qualcosa di buono per cui valga la pena lottare ma soprattutto, per cui valga la pena vivere.
Ora tocca a noi.
Vento dell’est,
la nebbia è là,
qualcosa di strano tra poco accadrà.
Troppo difficile capire cos’è,
ma penso che un ospite arrivi per me.
Walt Disney, Saving Mr Banks